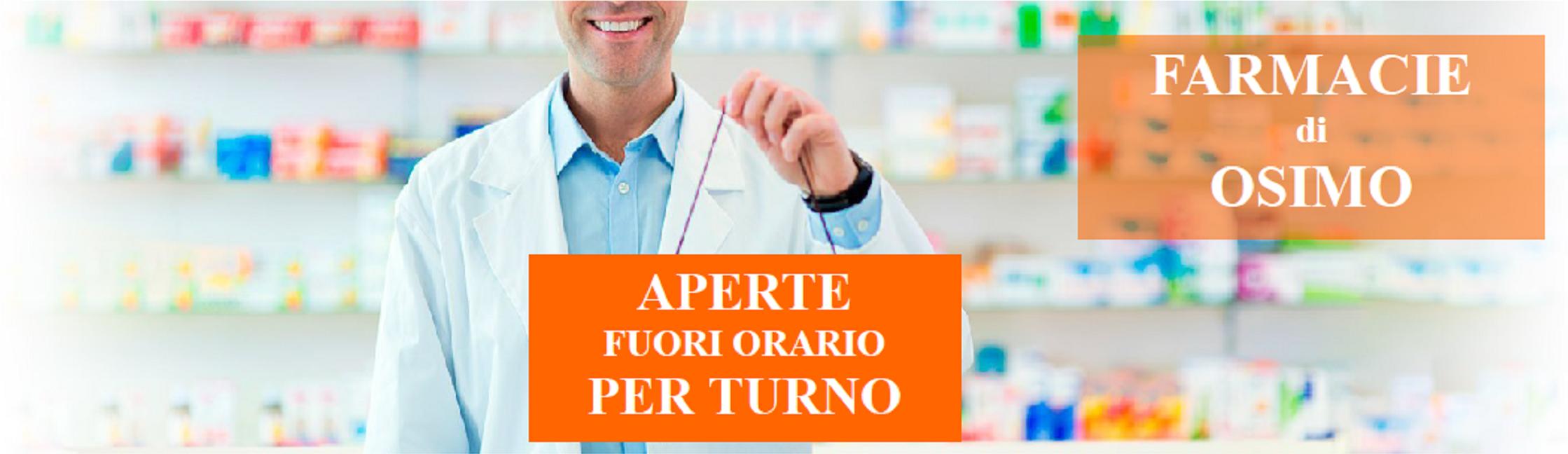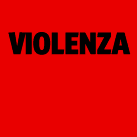Il 27 gennaio ricorre il 74° anniversario dell’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz.
Il 27 gennaio ricorre il 74° anniversario dell’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz.
Da allora, ogni anno nel Nostro Paese, in occasione di tale giornata vengono organizzate cerimonie, iniziative e momenti di riflessione per raccontare lo sterminio del popolo ebraico, che coinvolgono in modo particolare la scuola. Quest’ultima, soprattutto, è sempre fortemente impegnata, attraverso progetti culturali, seminari e incontri, nella tutela della memoria storica. Perché senza passato non c’è futuro. Perché la memoria storica è un prezioso diario che racconta le vicende umane, anche quelle di cui non andiamo fieri. E allora dobbiamo farci carico anche dei più efferati crimini che non abbiamo saputo e voluto evitare.
Tra le pagine più cupe della nostra memoria storica ce n’è una che non vorremmo mai ricordare, perché ogni volta che lo facciamo sprofondiamo in un baratro di orrore senza fine. Quell’orrore ha un nome, si chiama Shoah. E ci riporta con il pensiero ad uno sterminio sistematico che avvenne nel cuore dell’Europa e che trascinò alla morte 6 milioni di ebrei.
Il Nostro Paese, negli stessi anni, non fu immune dal male. Una delle pagine più tristi ed infamanti della storia del diritto italiano contemporaneo è rappresentata dalla legislazione antisemita del periodo fascista. I provvedimenti legislativi (leggi, regi decreti, decreti ministeriali, decreti legislativi del duce) ed amministrativi (circolari e ordini di polizia) emanati tra il 1938 e il 1945 dal regime fascista di Mussolini, resero la vita degli ebrei impossibile. Tanti treni partirono dall’Italia per deportare gli ebrei nei lager europei. Dalla stazione centrale di Milano, come ha tante volte ricordato la senatrice a vita Liliana Segre, partiva dal binario 21 un treno diretto d Auschwitz. Anche la signora Segre, allora tredicenne e “colpevole di essere ebrea”, fu ammassata nel convoglio RSHA insieme a tanti altri ebrei, per raggiungere il Lager in Polonia. Dei 10.000 ebrei presenti in Italia, 6.480 furono costretti a lasciare il Paese. Molti passavano per Trieste, alla Risiera di San Saba, l’unico Lager italiano che smistava i beni razziati, deteneva ed eliminava partigiani, detenuti politici ed ebrei e smistava i deportati in Germania, ma soprattutto in Polonia, ad Auchwitz.
Ma cosa fu realmente Auschwitz per i deportati? Auschwitz fu certamente la morte che poco a poco divorava la carne e l’anima dei prigionieri ormai senza nome, prigionieri ai quali si lasciava qualche goccia d’inchiostro sulla pelle in cambio di un’identità cancellata per sempre. Auschwitz fu il freddo nelle ossa, le gambe rinsecchite, il pianto dei bambini rimasti per sempre bambini. Fu file, fuoco, fumo, punizioni, gas, freddo, solitudine, paura. Fu un maledettissimo magnete in cui l’uomo seppe catalizzare tutta la sua malvagità. Auschwitz fu le mille facce del male, quel male che guardavano negli occhi fino all’ultimo respiro di vita, i condannati a morte. Auschwitz fu quell’”atomo opaco di male” che trasformava gli uomini in animali selvaggi, affamati, denutriti. Auschwitz fu la più grande negazione dei Diritti Umani.
Scrisse Calamandrei il più grande dei padri costituenti: “Questa è stata la pena più torturante: pensare che le nazioni civili di tutto il mondo, tra le quali la nazione italiana sa di avere il suo posto, abbiano potuto credere davvero che l’Italia, l’Italia di San Francesco e di Dante, l’Italia del Rinascimento, l’Italia del Vico, dell’Alfieri, del Foscolo e del Carducci avesse potuto rinnegare all’improvviso, per decreto di un dittatore, queste grandi idee di giustizia e di libertà civile, questa tradizione di umanità e di pietà che è la nota più costante e più profonda del nostro carattere; che l’Italia del Beccaria fosse potuta diventare un paese di carnefici e di torturatori, l’Italia del Mazzini un paese di nazionalisti oppressori dell’altrui libertà, l’Italia del Manzoni un paese di sconci razzisti.”
Un monito e un messaggio che arriva diretto ai giorni nostri.
Paola
Filed under: articoli giornali ed interventi | Tagged: 27 gennaio, abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, Auchwitz, Calamandrei, Liliana Segre | Leave a comment »