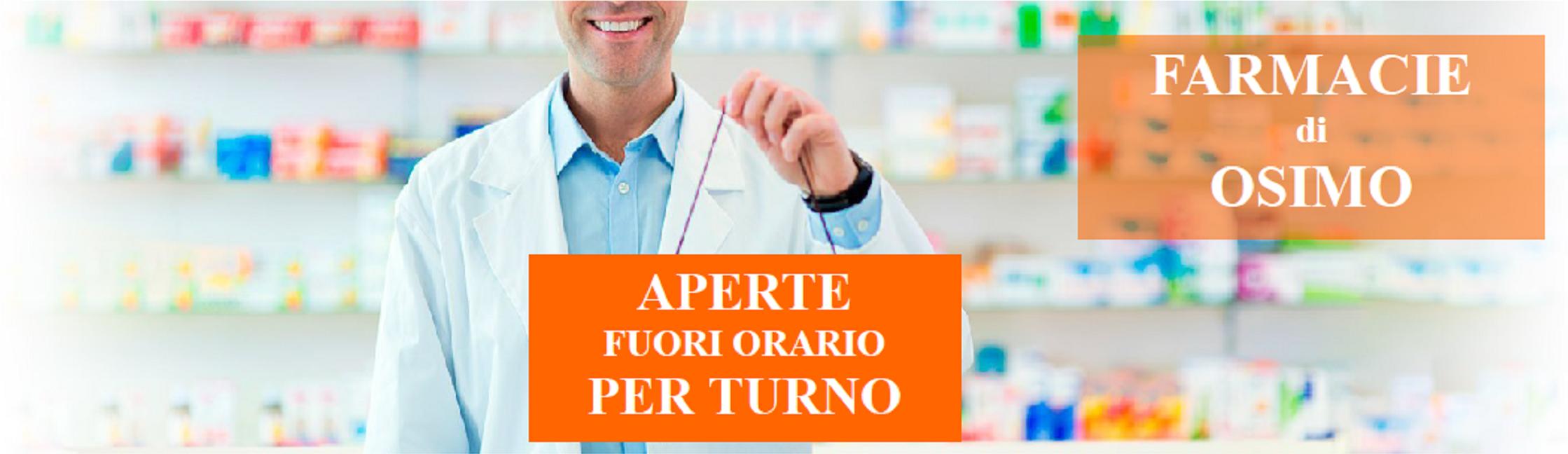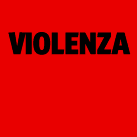Nei giorni scorsi ho letto sul Corriere della Sera una lettera che Romano Prodi ha inviato al direttore del giornale. Sono stata colpita dalla solita correttezza e onestà del prof. Prodi. Mi permetto di segnalarvelo e allego anche il link dell’articolo.
Approfitto per dire che Romano Prodi sarebbe, per me, il miglior candidato alla successione di Napolitano al Colle.
Paola
—————————————
![]() La politica e il lievito dei cattolici, 30 gennaio 2013, lettera di Romano Prodi al Corriere della Sera. Caro Direttore,
La politica e il lievito dei cattolici, 30 gennaio 2013, lettera di Romano Prodi al Corriere della Sera. Caro Direttore,
nei giorni scorsi, come spesso avviene nei momenti di svolta della politica italiana, i rapporti fra Chiesa e mondo politico hanno occupato grande spazio nei media e nei dibattiti.
La novità più interessante è costituita dal rilievo dedicato a un presunto unanime appoggio delle gerarchie ecclesiastiche a Monti e al suo ruolo futuro.Una tesi certamente confortata da una forte esposizione in questo senso da parte dell’Osservatore Romano e dell’Avvenire, alla quale sono seguite dichiarazioni altrettanto forti da parte di importanti autorità ecclesiastiche.
Si tratta di avvenimenti di indubbia importanza, dato che tutto questo combinato disposto sembra mettere definitivamente termine ad un appoggio aperto ed efficace di un’autorevole parte della gerarchia italiana nei confronti del presidente Berlusconi e dei suoi alleati di governo.
La presa di distanza da Berlusconi era iniziata ed era divenuta palese già da qualche mese ma le dichiarazioni in favore di Monti la rendevano più concreta e, soprattutto, comprensibile in modo inequivocabile da parte di tutti i cattolici italiani.
Questo nuovo corso ( a quanto si legge nella stampa) avrebbe dovuto essere solennemente consacrato da un convegno ( il così detto Todi 3 ) nel corso del quale i più visibili movimenti del cattolicesimo militante avrebbero dovuto solennemente confermare questa scelta.
È invece partita una dinamica del tutto imprevista perché questa nuova scelta non è stata condivisa da chi aveva sostenuto e continuava a sostenere le precedenti alleanze, mentre una rappresentanza non trascurabile per qualità e quantità dei cattolici militanti ha scelto di candidarsi nelle liste del Partito Democratico.
L’aspetto più interessante ( e a mio parere positivo ) di tutti questi eventi e’che nessuno sembra scandalizzarsi dell’esistenza di queste diversità di scelte e nessuno (come invece avveniva in passato) ha lanciato scomuniche o invettive.
In coerenza e forse in conseguenza di questi avvenimenti il così detto Todi 3 non ha avuto luogo e nessuno si è stracciato le vesti per la revoca di tale appuntamento.
La collocazione dei cattolici militanti in diverse caselle politiche ( evento che ritengo importante e positivo per la storia religiosa e politica italiana) e’ apparsa come un fatto scontato, quasi ovvio.
Come se gli avvenimenti degli ultimi anni avessero silenziosamente insegnato quanto siano delicate e non sempre positive le conseguenze di una stretta alleanza della Chiesa con un singolo leader o con uno specifico partito politico, pur nobile o corretto che esso sia.
Si sta cioè quasi istintivamente affermando nel mondo cattolico italiano (seppure in grave ritardo rispetto ad altri paesi) la convinzione che a coloro che operano nella vita pubblica sia sopratutto richiesto di portare un positivo contributo di esperienza, di etica e di dottrina nelle diverse appartenenza alle quali si decide di aderire in base alle proprie complesse scelte di carattere politico e culturale.
Essi sentono soprattutto un dovere: cercare di essere, seguendo la propria coscienza e i principi elementari del Vangelo, il lievito di una società sempre più secolarizzata, pluralistica e perciò sempre più bisognosa di un positivo fermento sviluppato dall’interno.
Forse sto cercando di trarre conseguenze troppo affrettate e generali da avvenimenti che sono ancora in corso di svolgimento e certamente questa mia interpretazione e’ influenzata dal fatto che una delle motivazioni principali del mio passaggio in politica ( verso la quale non sono né salito ne’ disceso) e’ stato proprio il desiderio di contribuire a che cattolici e laici operassero assieme nei diversi schieramenti.
Ritenevo e ritengo che, superati gli anni della grande emergenza del dopoguerra e del comunismo, questo sia un passaggio essenziale per fare operare insieme , in modo positivo, i principii che stanno alla base del Cattolicesimo e i fondamenti della nostra Costituzione.
Si tratta evidentemente di una posizione discutibile e, soprattutto, di una scelta che richiede un forte impegno di approfondimento e di testimonianza personale. Tuttavia pensavo e penso che una tale evoluzione possa aiutare la coesione del paese e una maggiore responsabilizzazione dei suoi cittadini.
La coalizione dell’Ulivo, intorno alla quale avevo cercato di costruire una proposta politica innovativa, aveva tra i propri principi fondanti anche questo obiettivo semplice ma di portata storica.
Come è noto le cose sono andate ben diversamente. Sono state infatti compiute precise alleanze e sono stati fissati confini inclusivi ed escludenti che, pur avendo provocato dolorose sofferenze, non mi sembrano avere dato risultati esaltanti. Ma il passato e’ passato. Conta invece il fatto che lo scorrere naturale degli eventi obblighi tutti noi a riflettere su questi temi e spinga qualcuno di noi a riscoprire il concetto di “lievito”. Questo e’ per me motivo di conforto.
Perché tale evoluzione possa produrre frutti di coesione e di miglioramento etico occorre naturalmente un mutamento altrettanto radicale nel comportamento dei partiti politici e degli stessi cattolici. Occorre cioè che sia dato un adeguato spazio al contributo dei cattolici e che essi, da parte loro, si facciano apprezzare per la qualita’ della proposta politica e non utilizzino l’ appartenenza cattolica come rendita di posizione.
In ogni caso quanto sta avvenendo in questi giorni all’interno del mondo cattolico e’ certamente un’occasione per una riflessione necessaria e positiva per tutti gli italiani.
Grazie dell’ospitalita’. Con molta amicizia, Romano Prodi
Filed under: articoli giornali ed interventi | Tagged: cattolici e politica, Corriere della sera, Romano Prodi | Leave a comment »